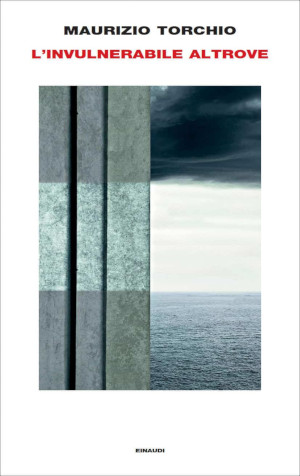Cattivi/Cattivi - voci dal carcere
Da mauriziotorchio.
< Cattivi
Cattivi - voci dal carcere
Cattivi, seconda opera di Maurizio Torchio, si colloca con efficace ambivalenza a cavallo tra il genere del romanzo e quello di memoir. Dalla tradizione memorialistica fluisce una narrazione in prima persona: a rammemorare fatti recenti o remoti, enucleando momenti salienti della propria esperienza, è infatti la voce di un carcerato, condannato a ‘un fine pena mai’.
Tale voce, tuttavia, non coincide con la persona dell’autore, e quindi è solo la forma del memoriale a supportare una costruzione che è, viceversa, finzionale. Non si tratta di fare, qui, una mera precisazione di genere, quanto di cogliere il significato preciso di una sfida che l’autore ha posto a se stesso e ai suoi lettori: come immaginare e ricreare l’esperienza carceraria, una delle più aliene “perché quelli di fuori al dentro non ci pensano mai”?
L’esito stilistico e strutturale di tale sfida è una narrazione compattissima, senza smagliature e concessioni al patetico; il carcerato che parla in prima persona lo fa con la parsimonia che la segregazione gli ha insegnato e con l’esattezza verbale di chi sa di avere sprecato la vita, e per questo non può che cercare di nominarla in maniera accurata, precisa. Coltivando in maniera impossibile, quanto incoercibile, una specie di fiducia in un dopo, “perché tutta la vita non consumata dev’essersi conservata, in qualche modo da qualche parte. Dovrà arrivare. Non può essere evaporata semplicemente passeggiando, dormendo”.
Il mondo nominato è principalmente sensoriale: i metri della cella, la qualità e quantità dei cibi, i rumori all’interno del carcere, gli insetti che entrano da fuori, la luce che filtra dalla finestra e indica la stagione, la comunicazione fra carcerati, guardie e secondini, gli oggetti che arrivano, tramite parenti amici visite dall’esterno, perché tutti i carcerati hanno una golosità incontrollabile per gli oggetti che portano i colori, le forme, la varietà del mondo libero. Il carcere è, infatti, prima ancora che coercizione e violenza, privazione di corpo e materia, come già aveva chiarito Michel Foucault nel celebre saggio Sorvegliare e punire. La nascita della prigione, uscito nel 1975. Lo dimostra in modo esemplare la perquisizione corporale con cui inizia Cattivi: ogni orifizio, ogni cavità e plica del corpo del detenuto, al rientro da un permesso, viene scrutata e ispezionata a marcare lo spossessamento di sé che il varcare la soglia del carcere comporta. E questo è solo l’inizio di una discesa in quello spazio sempre più angusto e asfittico, in cui anche la condivisione fra carcerati si rivela spesso frizione dolorosa di solitudini inemendabili, la convivenza con il personale di guardia un gioco terribile e massacrante alla sopravvivenza, che non è solo quella dei condannati, ma degli esecutori stessi della punizione, i carcerieri. Non c’è giudizio né sull’una né sull’altra parte, piuttosto la rassegnata constatazione che date quelle condizioni – il mondo-carcere – la dinamica fra gli umani, e perfino fra gli animali – i cani tenuti nell’intracinta muraria – non possa che essere questo: uno spiarsi a vicenda per reprimere la vita, castigarla in tutte le sue forme.
L’io narrante, colpevole di aver fatto parte di un sequestro di persona prima di essersi macchiato dell’omicidio in carcere di una guardia, ha in realtà già vissuto dalla parte del carceriere, nei lunghi mesi in cui in un dirupo montano ha tenuto prigioniera, legata a una catena, “la principessa del caffè”.
Quell’esperienza, centrale nel suo destino, è anche l’unica che si sottrae a un completo svuotamento; il suo significato, lungi dall’essere esausto, come quasi tutti i ricordi scavati e rivangati da un uomo che ormai si avvia ad avere vissuto in carcere più anni di quella che ha vissuto fuori, è forse anche la sua sola ragione di vita. Non solo perché si è innamorato di quella donna, ha cercato di rassicurarla, le ha parlato, ma anche perché ha capito una volta per tutte come l’esercizio del potere di vita e di morte sugli altri sia un’arma a doppio taglio che lega, in maniera indissolubile quanto ambigua, chi lo esercita e chi lo subisce.
Quest’uomo, di cui non sappiamo nulla se non che è cresciuto in una famiglia normale, con un padre e una madre amorevoli, che forse conserva ancora i segni di un’avvenenza giovanile, nonostante a furia di botte gli abbiano tolto tutti i denti e la sua voce sia frusciante come una foglia rivoltata dal vento, si è talmente assimilato al carcere da pensarlo come giusto per sé: “La cella è lunga quattro passi e larga un paio di braccia tese. Se mi alzo in punta di piedi tocco il soffitto. È uno spazio a misura d’uomo. A misura mia”. Un bisogno di contenimento che è regressivo, quasi pre-natale, e che culmina nel terrore che anche quello spazio si dissolva, quando in un finale onirico e allucinatorio l’io narrante immagina, o percepisce, che il carcere sia stato abbandonato da guardie e carcerati e che della sua prigionia non sia più padrone e responsabile nessuno. Un pensiero, questo, che anziché portare euforia annichilisce – segno che la punizione ha sortito appieno il suo effetto: chi ci parla non è più un uomo dotato di volontà e progettualità proprie, ma ‘un corpo docile’, che ha paura della propria stessa possibilità di scegliere e di essere libero. A distanza di due anni dal romanzo di Rosella Postorino Il corpo docile (Einaudi Stile Libero), è interessante osservare come la narrativa giovane italiana s'interessi al tema carcerario, non solo in relazione alla contingenza che vuole il nostro paese afflitto da un cronico sovraffollamento degli istituti penitenziari, ma nella prospettiva più vasta del problema esistenziale del libero arbitrio, e della relazione fra l’individuo e le regole della società in cui vive.