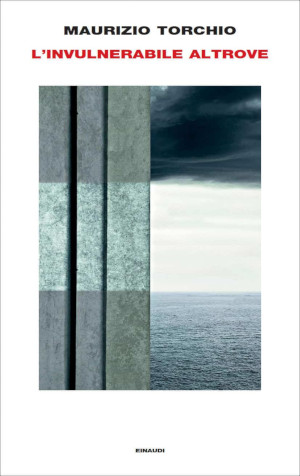Cattivi/I “cattivi” di Maurizio Torchio
Da mauriziotorchio.
< Cattivi
I “cattivi” di Maurizio Torchio
Mi piace leggere in treno. Soprattutto sul treno affollato del mio pendolarismo quotidiano, gomito a gomito con uomini assonnati, ragazze che si mettono il mascara guardandosi gli occhi in minuscoli specchietti, appassionati di videogiochi ipnotizzati dai micro video dei loro smartphone, colorati da simbolini in stretta fila. Mi piace quel progressivo distaccarsi, quel precipizio di parole che lentamente annulla i suoni, gli odori, lo sbatacchiare del vagone sui cambi quando si prende velocità. Ma in modo particolare mi è piaciuto leggervi Cattivi, l’ultimo libro di Maurizio Torchio (Einaudi 2015): un romanzo quasi tutto al chiuso (tutto avviene in situazioni di prigionia) cui si contrappone la vertiginosa uscita della voce di un uomo che trova in un monologo sempre più radicale e profondo una via per dare significato alla propria invisibile, tragica esistenza.
Vale la pena dirlo con chiarezza: Cattivi è un romanzo molto bello, che conduce il lettore sul crinale di un abisso. Da una parte il basta – fino a dove può spingersi la resistenza di un essere umano?; dall’altra l’ancora di una scrittura pressoché perfetta, talmente controllata da sembrare la più naturale del mondo. Salutato fin dai suoi esordi come una delle voci più promettenti della narrativa nazionale, Torchio affronta un romanzo sul carcere entrando nella pelle di un criminale innocente e assumendone muscolatura e scheletro, organi vitali e linfa, mente e voce. Un’immersione talmente radicale e riuscita da rendere ragione a una letteratura immaginifica, capace di fornire sentimento e significanza a ciò che sentimento e significato sembra non avere: la prigionia, che scolpisce e immobilizza anche il tempo, avvinghiando al suo presente carcerati e carcerieri, dove ogni azione, ogni pensiero, ogni ricordo, ogni rumore, ogni oggetto, ogni suono, ogni speranza, ogni amore ne risulta amplificato. Eppure non si tratta di un romanzo di mera denuncia, anche se il carcere quale possibile luogo rieducativo ne esce a pezzi. Torchio evita con maestria il tono giornalistico cui siamo sempre più abituati portando la tragedia del carcere al livello dell’esperienza di un uomo, del suo modo di leggere la realtà, di rimettere in ordine la propria vita, e dotando quest’uomo – di cui mai sapremo il nome – di una voce straordinariamente calma, affettiva, a tratti quasi infantile. Una voce che registra ogni dettaglio, e proprio grazie a questa registrazione amplia il carcere fino a farlo diventare il luogo dove tutto il male – ma anche tutto il bene – può accadere.
La prima, brutale cosa che accade riguarda i corpi, la loro trasformazione. Non dovrebbe essere sorpresa per nessuno, lo sappiamo da sempre che cosa la prigionia può fare a un uomo – sempre che sia ancora un uomo, diremmo con Levi. Eppure, entrare in contatto con la brutalità sconvolge ogni volta come fosse la prima. Sentire il rimpianto per l’odore del pane, immaginarsi di rinunciare alla propria dentiera, invecchiando di colpo di anni, solo per non essere soggetti al ricatto di chi potrebbe togliertela da un momento all’altro; o, ancora, quella sensazione di isolamento al quadrato: non solo la nuda cella dove stai da solo, ma nessuno, mai, che ti tocchi senza mettere i guanti: che sensazione può dare toccare la pelle di un altro?
Ma accade anche altro. È stato scritto che Torchio ha rimescolato le carte dell’ideologia vittimaria. Non vale solo per la figura del protagonista, criminale innocente, come si è detto all’inizio. Perché, fatte le dovute differenze, al carcere appartengono anche i carcerieri, la cui vita risulta tanto più brutale quanto più misera, legata a una quotidianità di gesti umilianti (per tutto bastino le perquisizioni corporali con cui Torchio apre il romanzo). Diceva Simone Weil che quando si ha a che fare con la forza, nessuno ne è immune, tantomeno chi impugna la spada. E difatti, si trasformano – o forse finiscono a fare quel lavoro perché già trasformati – anche i carcerieri. Per certi versi, il loro abbrutimento appare ancora più pervasivo, irrigidito dalla burocrazia: alla cura quasi ossessiva che il carcerato pone nel pulire e sistemare la propria cella – uno dei pochi atti di libero agire dove torna a sentirsi uomo fra gli uomini – si contrappone quella sciatteria, quella rabbia scaricata sugli ambienti che tutti abbiamo imparato a riconoscere in molti edifici dello Stato, terra di tutti e di nessuno.
Torchio però è andato oltre. E lo ha fatto con un notevole scarto narrativo, vale a dire il reato che conduce il protagonista in prigione: la custodia forzata di una giovane donna (la figlia del re del caffè) rapita per riscatto. Carcerato e carceriere si fondono così nella stessa persona e la storia assume, anche per l’ambientazione scelta per la custodia della donna – una grotta nascosta da una fitta vegetazione – dei tratti quasi mitici. Come non pensare alle tante principesse dalla caviglia incatenata, che l’iconografia pittorica italiana ha immortalato accanto a draghi infilzati dalla lancia di San Giorgio? E come non pensare, anche rispetto al titolo di questo romanzo, al piccolo drago salvato dalle pagine di Anna Maria Ortese? E come non pensare alle tante favole della tradizione popolare che si rispecchiano nella più nota La bella e la bestia? L’ultimo degli ultimi, il reietto per eccellenza (che altro era il drago?) arriva a custodire nella sua grotta il simbolo di una bellezza irraggiungibile. Non può che trattarla alla sua maniera – ovvero sia da drago, seppur piccolo. Ma il suo cuore si riempie di un amore inconfessabile, che sarà non solo la sua rovina (in senso stretto, la causa del suo arresto), ma anche il filo di Arianna capace di trarlo fuori dal labirinto dell’isolamento forzato, dal terrore che il suo nome scompaia senza che alcuno ne conservi traccia e memoria. Un’operazione talmente riuscita, questa di Torchio, che perfino il lettore fatica a percepire come drammatici i dati di realtà: la catena che imprigiona la donna, il freddo, l’orecchio tagliato, il terrore quotidiano.
In un’intervista a Fahrenheit, Torchio ha detto che in fondo il suo romanzo è un romanzo rosa, che senza le storie d’amore (quella della voce narrante per la donna rapita, quella del comandante del carcere per una professoressa, a sua volta innamorata di un detenuto, quella di tutti i carcerati per le storie d’amore tout court) tutto crollerebbe. È vero, e non solo in senso narrativo: nell’orrore di una serie infinita di crudeltà tratte dalla realtà carceraria – nulla d’inventato, tanto per essere chiari – quel che permette la sopravvivenza è l’amore, vissuto in prima o per interposta persona. Laddove la vita si riduce a pochissimo, la mente amplifica le sue possibilità, dispiegando le sue grandi ali in un cielo fatto di speranze, di sogni, talvolta di utopie. Ma anche l’azione, in questa nudità, risalta: in tutta la sua terribile violenza (vale per la grotta come il carcere) e in tutto il suo splendore, e la libertà individuale diviene una questione di scelte assolute – per tutto, basti il rapporto (in parte raccontato anche dai Dardenne in Il figlio) fra un padre e l’assassino del figlio, volutamente chiusi nella stessa cella. Se ne è sorpresi, ma in fondo neanche tanto. La possibilità di restare uomini laddove tutto concorre a ridurti a niente è qualcosa che da sempre ci racconta la letteratura legata alla prigionia: si pensi ai romanzi, ai diari, ai quaderni filosofico-politici, alle lettere, ai manifesti, solo per citare possibili piste italiane. Nell’orrore, solo ciò che abbiamo dentro ci può aiutare: un versetto di Dante; una visione europea; un mondo più giusto; una fede; un amore. Il cattivo di Torchio non fa eccezione.