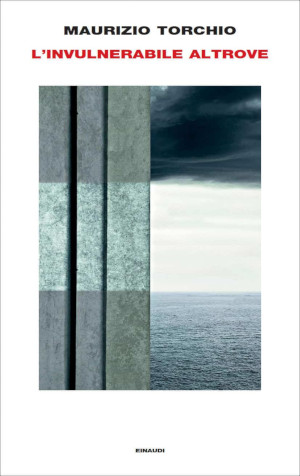Cattivi/In cattività, ovunque
Da mauriziotorchio.
< Cattivi
In cattività, ovunque
Dopo aver poggiato per la prima volta Cattivi sul comodino – ero arrivato verso pagina 40 – mi sono scoperto ad accendere il computer e cercare “Maurizio Torchio”, per vedere se era stato un carcerato: la sua bibliografia in bandella elencava altri due libri, ma per quanto ne sapevo, e anche a fronte di ciò, Maurizio Torchio poteva ben essere stato in galera. Ciò che fa venire un simile dubbio non è solo la quantità e qualità dei dettagli presenti in Cattivi – gli oggetti nuovi, mandati da fuori, che “proteggono”, anche dalla violenza, perché una cella senza oggetti è la cella di qualcuno di cui a nessuno frega più niente; la requisizione delle dentiere ai capi, più anziani, per stroncarne anzitutto l’auctoritas; l’importanza e la funzione simbolica della pulizia della cella, solo per citarne alcuni – ma anche la naturalezza con cui vengono disseminati: la percezione, quella sì, panottica, di ogni dettaglio dell’universo carcerario. Tra i vari risultati proposti da Google, ho trovato un’intervista in cui l’autore racconta come è nata l’idea del libro. Da essa si può pacificamente concludere che in prigione non c’è stato. In ogni caso, portandomi a fare una simile ricerca, aveva già vinto lui.
Cattivi va tuttavia oltre la semplice mimesi, che del resto non è l’intento finale, visto il divario tra il modo in cui si esprime il protagonista e voce narrante, e il suo supposto livello di scolarità: quello che fa è attuare un gioco di specchi, tra il detenuto in galera e il suo essere stato carceriere (in quanto rapitore), nella vita precedente, e da lì, proiettando la possibilità del carcere altrove, la proietta ovunque, rendendo la galera alla sua condizione di assoluto.
Proprio per tale natura archetipica, oltre che per la naturale efficacia narrativa di un contesto a quantità circoscritta di figure e spazio (e, potremmo aggiungere, per il tasso di incarcerazione degli USA), quello carcerario è un filone fertile nel cinema, nel fumetto e nella narrativa americana, al punto che ormai esistono, e da tempo, pure le metanarrazioni carcerarie, penso ad esempio a quelle di Azzarello nell’arco Chill in the oven di 100 bullets o nella miniserie Hard Time in Hellblazer. In Italia, però, la galera è uno dei grandi non detti: meno se ne parla e meglio è – il primo esempio che mi viene in mente: quanti sono quelli che, come me, sono venuti a conoscenza della vicenda di Marcello Lonzi, ucciso a forza di botte nel carcere di Livorno, per via di manifesti affissi in giro, più che attraverso i media tradizionali? Scommetto molti – e non solo sui giornali: sebbene esistano alcune significative riflessioni accademiche e politiche sul carcere (recentissimo è Cosa è il carcere di Salvatore Ricciardi), anche livello narrativo, e più in generale artistico, si è visto poco.
Nel cinema c’è qualcosa: possiamo trovare il carcere femminile di Nella città l’inferno di Renato Castellani e quello minorile di Mery per sempre di Marco Risi, la Rebibbia di Cesare deve morire dei fratelli Taviani, il carcere di Genova del bel La bocca del lupo di Piero Marcello. Ma in letteratura, fino a non molto tempo fa, c’era poco. Un recente articolo di Graziano Dell’Anna ha mostrato come negli ultimi anni sia fiorito un piccolo canone rebibbiese, formato da sei romanzi, di cui ben quattro usciti negli ultimi dieci anni, ambientati nel carcere romano (in ordine temporale, L’università di Rebibbia di Goliarda Sapienza, uscito nel 1983, Maggio Selvaggio di Edoardo Albinati (del 1999), Libera i miei nemici di Rocco Carbone (2005), Il sogno cattivo di Francesca D’Aloja (2007), Dentro di Sandro Bonvissuto – specificamente il primo e più lungo racconto del trittico, Il giardino delle arance amare – del 2012, Il corpo docile di Rosella Postorino, del 2013). Se Cattivi non fa parte di tale lista è solo perché essa si riferisce esclusivamente a Rebibbia, mentre il carcere di Torchio, come ogni cosa nel romanzo, è privo di specificità geografica (per quanto alcuni rimandi a un precedente carcere isolano possano far pensare a Pianosa o ancor più probabilmente all’Asinara), ma lo si può ben aggiungere ai succitati, e formare così un canone non più rebibbiese, ma carcerario tout court.
Perché prima di questi romanzi, nella letteratura italiana, c’era davvero poca galera (c’era più confino, per ovvi motivi, e infatti anche Il carcere di Pavese, al di là del titolo e nonostante il passaggio dell’autore da due prigioni prima di approdare a Brancaleone di Calabria, a tale esperienza fa riferimento). Per trovare qualcosa tocca andare indietro fino al biennio 1832-33, in cui uscì Le mie prigioni di Silvio Pellico e fu scritto Manoscritto di un prigioniero di Carlo Bini. Ma il carcere di oggi, per quanto – essendo un assoluto, nonché per più di un verso un cascame di epoche ormai passate – abbia punti in comune con quello del XIX secolo, è anche altro. È anche quello visto al cinema, letto nelle pagine dei narratori americani, primo tra tutti Bunker (non a caso citato nei ringraziamenti da Torchio), e non solo nella testa del lettore o dello spettatore, giacché le narrazioni alimentano la realtà non meno di quanto accada l’inverso; è quello di Fuga da Alcatraz e Le ali della libertà e poi ancora di The Wire e Orange is the new black – un carcere, in buona sostanza, postmoderno, e come tale capace anche di sollevarsi dalla piena aderenza a sé, e di diventare vettore e prisma di contenuti altri.
Credo che, chiudendo il libro di Torchio, tra le prime cose che possono venire in mente al lettore italiano, prima ancora di Falconer di Cheever o delle varie incursioni di King nel genere, ci sia l’atmosfera che si respira durante la reclusione di Klaus Haas, nipote di Hans Reiter/Benno von Arcimboldi nella Parte dei delitti del 2666 di Roberto Bolaño, anche per via di una centrata soluzione “latina”: il carcere di Cattivi, infatti, viene efficacemente collocato da Torchio fuori da uno spazio e da un tempo preciso ibridando elementi normalmente inesistenti nella stessa epoca: ci sono detenuti politici, dettaglio da Italia anni ’70, e ci sono i giovani e tatuati Enne, sorta di mara sullo stile della Salvatrucha o della Calle 18, nota decisamenta contemporanea, oltre che estera.
Allo stesso modo ci sono elementi come il prolungato isolamento che se da un lato, come nota Giacomo Raccis in una centrata recensione, portano a una scollatura dal realismo, dall’altro assolutizzano il carcere torchiano, lo rendono fulcro di un intero sistema di riferimenti, e quindi, per quanto ci riguarda, più vero del vero. Tutto questo è reso possibile anche da un preciso e icastico lavoro su lingua e struttura: ogni cosa è ridotta al minimo e al necessario, ogni figura si sublima nel suo archetipo (e a volte, come in un ulteriore, estremo sprofondamento alle sorgenti del senso, nel suo opposto: la guardia si scopre reclusa, il recluso si ricorda carceriere, il “fuori” diventa l’ombra del “dentro”), e le forze in campo, il “male” che porta in galera e quello che fa agli uomini la galera, si sublimano a funzioni dharmiche, di legge naturale, più che karmiche, facendo sì che Cattivi, con una simile purezza, non solo fissi definitivamente i parametri di un filone recente della nostra narrativa, ma ne costituisca addirittura una possibile conclusione.