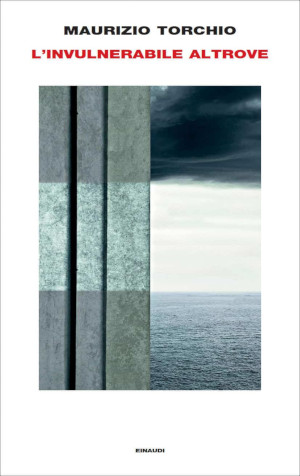Cattivi/Intervista a Maurizio Torchio
Da mauriziotorchio.
< Cattivi
Intervista a Maurizio Torchio

Lo incontro a Villacidro, gli auguro buon appetito: sta cenando assieme ad altri finalisti della XXX edizione del Premio Letterario Giuseppe Dessì. Ci accordiamo per un caffè la mattina successiva: ancora non sappiamo che sarà il vincitore della sezione Narrativa del Premio, per il momento è solo uno dei tre finalisti. Gli dico che ho dimenticato i soldi per il caffè, ride e mi dice: per un caffè li ho. Intervisto con piacere Maurizio Torchio sul suo libro, sulla scrittura e sulla condizione di cattività che unisce carcerati e carcerieri. Per la cronaca alla fine il caffè ci viene offerto: che nessuno metta in dubbio quanto i sardi siano ospitali. La foto è di Alessandro Loddi.
Il tuo romanzo Cattivi, pur essendo narrato in prima persona da un detenuto, ha un titolo al plurale. Perché questa scelta?
Perché il carcere è una realtà sociale molto articolata, come di fatto tutte le realtà sociali, e alla fine io l’ho raccontato con una voce sola, la voce del carcerato dei carcerati, del prigioniero dei prigionieri, perché ho visto che era possibile raccontarlo tutto a partire dal suo punto più deprivato di esperienze; era possibile e forse l’unico modo in cui mi veniva bene. Però resta il fatto che le storie di carcere sono storie di persone diverse, di reclusi diversi, di guardie e di detenuti e quindi la condizione di cattività accomuna e in un certo senso avvelena sia chi detiene le chiavi che chi in qualche modo le subisce.
Qui al Dessì nel 2012 si è premiato il racconto lungo Dentro di Sandro Bonvissuto, anch’esso incentrato su un detenuto. A livello puramente narrativo cosa pensi di questo luogo disumano, perché affascina tanto i lettori e gli scrittori?
Il fascino verso il carcere ha radici profonde. Pensiamo alla filmografia carceraria negli anni Venti negli Stati Uniti: si producevano anche trenta film a tema carcerario ogni anno. Andando ancora più indietro, nell’Ottocento si è sviluppato enormemente il fascino letterario verso la cosiddetta “prigione romantica” con un fiorire di racconti e romanzi che avevano come soggetto le figure parallele del carcere: c’erano le “monacate” per forza, i carcerati e i sepolti vivi. Attorno a questo trio si giocavano le paure del secolo ma anche l’attrazione verso una condizione di clausura più o meno forzata, dalla quale ci si aspettava un potenziamento delle capacità di introspezione dell’individuo. E questa è anche l’aspettativa dei riformatori carcerari, il pensiero che ha portato alla nascita dei penitenziari moderni. Dal carcere come bolgia, in cui venivano mescolati fra loro criminali di lungo corso e ragazzini, ci si evolve al Penitenziario. Un luogo che nella sua idea originaria e nei suoi esempi più puri, come i quaccheri negli Stati Uniti, era il regno del silenzio, dell’isolamento, del vuoto e proprio questo vuoto avrebbe dovuto facilitare la presa di contatto con il proprio passato e la propria storia. Indipendentemente da queste aspettative, purtroppo nel mondo reale i luoghi di detenzione hanno spesso causato tragedie: in questo vuoto pneumatico l’esito è la follia non certo fare i conti col proprio passato. Eppure la voglia di capire nel profondo cosa succede a parole, mente, pensieri e corpo umano in una condizione così innaturale è rimasta, e allora ci si accosta al carcere per vedere, quasi in un esperimento da laboratorio, cosa non è possibile togliere deprivando l’uomo di ogni cosa e in che modo si potenzia (pur distorcendosi) quel poco che non è possibile togliere.
Lo stile di scrittura serve a elevare o a rappresentare una storia?
Nel mio libro serve a rappresentare, sicuramente. Mi pare la risorsa, la forza e mi viene da dire anche il dovere di un racconto sia questo: il raccontare per raccontare.
Perché un lettore dovrebbe leggere Cattivi?
Questa è un po’ difficile... Un lettore può voler leggere Cattivi per ritrovare alcune domande che lui probabilmente si pone, come ce le poniamo tutti. Domande semplici che però, per chi se le fa, sono spesso drammatiche allo stesso tempo... Che ne è del tempo perduto? Come si sono spesi gli anni che ci sono stati dati? La paura di invecchiare e quella ancestrale della morte: cosa resterà dopo? Queste domande classiche ma non di meno di un certo rilievo per chi sulle loro risposte riflette, nel contesto carcerario assumono una eco diversa, allo stesso modo in cui risuona diversamente la voce umana all’interno del carcere. Fra le mura della cella la voce ha un altro suono, vibrano i pensieri in un luogo in cui domina il cemento, in cui c’è poco di organico e quasi niente di soffice e quindi sentire come si trasformano queste domande in una condizione di reclusione, innaturale e differente dal quotidiano, può forse interessare i lettori.
Immagino che portare a termine un libro sia anch’essa una condizione di reclusione, ma all’interno di se stessi. Cosa fa Maurizio Torchio per restare là, inchiodato in quella stanza immaginaria?
Esattamente come per il protagonista del libro, e come in molti casi accade nel mondo reale, a volte può essere più difficile uscirne che restarci. La claustrofilia è una possibilità che può toccarci anche nel più ostile degli ambienti. Scrivendo questo libro ho imparato molto; mi ha dato l’occasione per leggere tanto e per incontrare delle persone. Dopo un po’ mi ero ricavato una mia “nicchia ecologica” all’interno di quell’ambiente, immaginario e reale insieme. È stato davvero difficile dire basta e decidermi a congedarmi da quel microcosmo, non importa quanto familiare ormai lo sentissi.