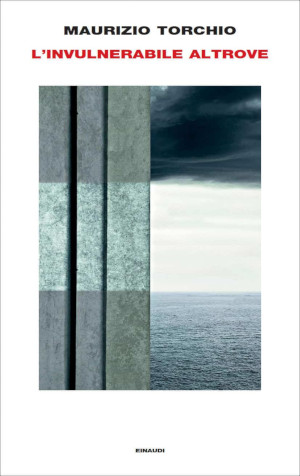Cattivi/Le carceri sono le viscere del mondo
Da mauriziotorchio.
< Cattivi
Le carceri sono le viscere del mondo
La narrazione delle situazioni estreme, di quelle situazioni-limite che si pongono ai bordi dell’ordinario e che da questo punto di vista, non di rado paludoso e sfuggente, lo svelano nelle sue dinamiche perlopiù irriflesse, si espone sempre a un doppio pericolo: quello della riduzione e quello dell’enfasi.
La riduzione è il non riconoscimento della differenza, è lo scioglimento dello straordinario nell’ordinario o dell’ordinario nello straordinario; è il tentativo di smussare gli spigoli taglienti dentro una omogeneità che si articola al massimo per differenze di grado, la pretesa di descrivere dentro una grammatica unitaria forme di vita che si distinguono invece proprio in quanto reciprocamente altre e vicendevolmente intraducibili.
L’enfasi, viceversa, è perlopiù segnata dalla retorica dell’inesprimibile, dalla ricerca di una differenza del tutto estranea alla dimensione del consueto, dall’emergenza di una lingua e di una struttura logico-sintattica tutte tese a rendere decisamente e vigorosamente sonora l’estraneità di cui si sta parlando.
Maurizio Torchio, nel suo formidabile Cattivi (Einaudi, 2015) – una sorta di diario sublimato di un ergastolano che racconta la vita in detenzione e le vicende che lo hanno condotto alla reclusione – nel descrivere quella situazione limite del mondo e dell’esistenza che è appunto il carcere, riesce a tenersi in bilico, con rigore di scrittura e straordinaria forza descrittiva, sopra questa lama di rasoio affilatissima che potrebbe diventare lacerante e distruttiva ad ogni ulteriore passaggio, ad ogni cambio di pagina, a ogni spostamento di fuoco della struttura narrativa.
Cattivi è il resoconto in prima persona di uno sguardo lucido e consapevole che descrive se stesso e il mondo a partire dai limiti estremi in cui si colloca. La voce narrante – il testo è appunto scritto tutto in prima persona – è quella di un recluso, condannato dapprima per sequestro di persona e poi, definitivamente, per l’uccisione, a un tempo non decisa eppure in qualche modo necessaria, di una guardia che si è trovata ad agire in un modo assurdamente inconsapevole delle norme costitutive di quella comunità che è quella dei reclusi, dei cattivi, e che tiene insieme, in una dinamica di mutua dipendenza, carcerati e carcerieri.
Il libro racconta dunque dall’interno – verrebbe da dire, dal punto più interno di questa internità opaca, chiusa e impermeabile – la vita/non-vita del carcere, le sue dinamiche più ancestrali, le gerarchie chiare e nitide che si vengono a formare e che vengono ad assumere una funzione regolatrice essenziale nel movimento dei reclusi, le geografie interne di questo mondo a parte, dove i piani e i corridoi rappresentano territori dotati ognuno di una propria specifica legislazione. Di questa realtà insieme il racconto espone le sue logicissime irrazionalità e soprattutto dipana le grammatiche esistenziali di questi corpi dai quali non si può mai cancellare del tutto il desiderio, perché l’assenza di desiderio toglierebbe anche il senso stesso al dolore della reclusione.
I limiti di qualcosa sono sempre ciò che determina e costituisce il modo d’essere di quella cosa: i limiti evidenziano la fisionomia e i tratti un mondo; i limiti sono ciò che definisce la specificità e irriducibilità di una situazione. Al contempo, in quanto limiti, essi sono anche, sempre, l’al di là di quella cosa, l’altro rispetto al mondo che tratteggiano, l’esteriorità rispetto alla situazione che definiscono. Un limite, infatti, per essere davvero tale, deve anche essere, sempre e necessariamente, l’esperienza dell’ambito disomogeneo in cui la cosa non è più se stessa, in cui un mondo perde la sua consistenza, in cui una situazione si rovescia nell’altro di sé stessa.
Il carcere, questa regione estrema della realtà descritta da Torchio con scientifica accuratezza e autentica adesione esistenziale, è in qualche modo il limite del mondo e della vita. E a sua volta l’isolamento, ovvero la condizione nella quale si trova la voce narrante, è il carcere del carcere e, dunque, in quanto suo limite estremo, il punto di vista che rende osservabile e descrivibile, nella sua specifica consistenza, il carcere stesso.
Come se il mondo fosse sempre e solo osservabile dal luogo in cui esso smette di essere ciò che è.
Le carceri, dice il protagonista, “sono le viscere del mondo” (118).
E come i limiti, come i bordi, come i confini, anche le viscere del mondo, per quanto facciano decisamente parte del mondo, non sono visibili al mondo. Anzi, svolgono la funzione che svolgono proprio in quanto invisibili, in quanto sottratti allo sguardo del mondo. Le carceri sono quel luogo nel quale il mondo lascia marcire i propri resti; una sorta di anti-mondo che, nella sua assoluta chiusura e oscurità, svolge una funzione insieme rassicurante e minacciosa. Un anti-mondo che, proprio per la sua intima e peculiare specularità rispetto alla forma di vita a cui si trova contrapposto, si costituisce come una sorta di universo parallelo. Il carcere è in questo senso uno spazio retto e governato da una sua specifica, assurda e insieme ferrea e folle, regolarità, un mondo nel quale si vengono a produrre peculiari dinamiche di potere e sottomissione, grammatiche vitali e sintassi sociali irriducibili a quelle del mondo di fuori e, al contempo, speculari ad esse e rivelative di esse.
Ciò che è al centro della scrittura di Torchio è qui, in questa sorta di romanzo esistenziale, quella che verrebbe da chiamare la logica della reclusione. Una logica che coinvolge e costringe carcerati e carcerieri: tanto il direttore del carcere (Comandante), che si trova immischiato e ricattato da una storia d’amore tra un carcerato e una donna che vive di una vita normale (Martini e la Professoressa), quanto i famigliari dei reclusi, le mogli e i figli (dolorosissime e potenti le pagine che descrivono le visite in carcere dei bimbi e delle donne), quanto anche gli agenti. Una logica nella quale ognuno è solo con se stesso e insieme trova il proprio senso solo negli altri, in quelli che vivono fuori, i quali, anche nell’assenza, determinano il modo d’essere dei reclusi; una logica insieme assolutamente primitiva e rigorosamente coerente, che si regge tutta sulla violenza e sulla minaccia della morte. Una logica che, come di riflesso, svela, la realtà stessa dell’esistenza.
Una logica nella quale solo la privazione, la mancanza e l’assenza sembrano in grado di rendere la vita consapevole di se stessa. Non nel senso che la privazione redima, salvi e trasfiguri. Per quanto lontanissimo dal tono della denuncia sociologistica sull’invivibilità della condizione carceraria, Torchio, in questa sua scrittura che non giudica delle vite perché è piuttosto come un’anatomia della vita, mette in evidenza l’assoluta assenza di una qualsiasi visione salvifica nella reclusione:
“il carcere non serve a restituire al mondo” – dice il protagonista; il carcere “è fatto per chiudere, coprire, cicatrizzare. Può chiudere in modo sporco e caotico, oppure sterile e giusto” (178), ma è evidente che il carcere è fatto per mettere da parte e per togliere, non per includere e restituire.
Quando il carcere ti dà qualcosa è per farti sapere che può togliertelo: “Per farti provare la sensazione di cadere, ti sollevano ogni tanto. Altrimenti dopo un po’ arrivi al centro della terra, e da lì non vai più da nessuna parte” (11).
Anzi l’annientamento non deve mai essere integrale: anche se non esiste la speranza di uscire, il carcere “ti costringe a continuare a pensare al dopo” (167): di questo pensiero ne ha bisogno in realtà in primis il carcere stesso: per potersi reggere e per potersi giustificare; perché solo il desiderio di una vita diversa è la condizione di esistenza del carcere, ciò che ne giustifica la specifica meccanica: “dev’esserci sempre qualcosa da togliere, altrimenti tutto si ferma. A volte ti danno delle cose perché ti venga paura di perderle” (11).
Resistere, nel carcere, significa non chiedere quello che ti serve. Perché nel momento in cui ti viene dato ciò che ti serve, sanno anche che te lo possono togliere: “A me hanno spaccato tutti i denti, ma la dentiera non l’ho chiesta (…) La dentiera è un’arma nelle mani dell’amministrazione” (29).
E non a caso nel carcere i reclusi, dice il protagonista, osservandoli dall’isolamento in cui si trova e che nella sua orribile invivibilità appare talvolta addirittura come una assurda dimensione di privilegio, impazziscono per i regalini: “In carcere ho visto rivolte sventate distribuendo caramelle. Giuro: caramelle. Da prigioniero hai gli sbalzi di umore dei bambini, perché qualsiasi cosa, anche la più piccola, ti occupa subito tutto il campo visivo” (59).
Il racconto di Torchio rende tangibile in modo davvero straordinario questa sorta di movimento incessante che caratterizza l’esistenza nel tentativo di costruirsi assurdi, eppure decisivi, coaguli di senso anche là dove il senso è totalmente annullato, questa sorta di bisogno primario di produrre briciole di significato anche dentro la sua più radicale disintegrazione. Un movimento che si ripete e si riproduce indefinitamente anche nella più disumana delle condizioni, anche nel dolore estremo e nella povertà assoluta. Come se qui, dentro questo mondo dove una logica folle e stringente arriva a giustificare l’illogico stesso, ci fosse la possibilità di guardare e toccare nella sua nudità e semplicità, quel conatus in existentia perseverandi che è la vita stessa, che è l’origine e la scaturigine del respiro stesso che segna la fatica del tenersi in vita.
Al di là di qualsiasi impossibile redenzione, al di là di qualsiasi sillogistica consequenzialità; al di là, appunto, di qualsiasi senso.