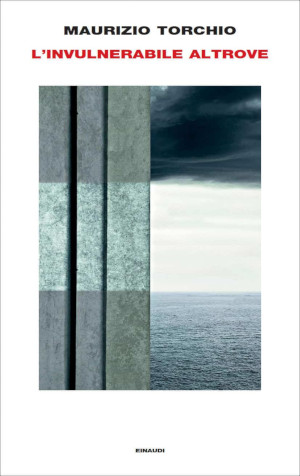Cattivi/Maurizio Torchio dà voce alla lingua imprigionata
Da mauriziotorchio.
< Cattivi
Maurizio Torchio dà voce alla lingua imprigionata
Il monologo di un ergastolano disegna uno spazio chiuso per il quale il mondo “fuori” non riveste più alcuna importanza
Se un giorno mi decidessi a scrivere, su letteratura e carcere in Italia, quel libro che vagheggio da tempo, muovendo dal Silvio Pellico di Le mie prigioni (1832), dalla pallida ombra di se stesso che diventò dopo lo Spielberg, ma anche dal Carlo Bini del Manoscritto d’un prigioniero (1833), stilisticamente assai più euforico, per arrivare sino al nostro oggi, non potrei tacere dell’ultimo lavoro di Maurizio Torchio, Cattivi, non foss’altro che per la sua originalità di sguardo: un’originalità che di certo discende dalla nuova consapevolezza che, sul discorso carcerario, ha imposto, alla comunità storico-filosofica e scientifica, Sorvegliare e punire: la nascita della prigione di Michel Foucault, stranamente non citato, in coda, tra i tanti scrittori cui Torchio tributa il suo grazie. Quel Foucault, per capirci, che ha fatto della condizione carceraria un problema di sintassi e codici, quale articolazione d’una più vasta microfisica del Potere, in riferimento al rapporto tra spazio e corpo, e, diciamo così, alle tecniche di controllo e alla disciplina coercitiva. Ce ne rendiamo subito conto davanti ad affermazioni come queste, ineccepibili nell’impostare la questione in termini grammaticali, di grammatica della detenzione. Indugio: «La cella è lunga quattro passi e larga un paio di braccia distese. Se mi alzo in punta di piedi tocco il soffitto. È uno spazio a misura d’uomo. A misura mia. L’isolamento è la prigione della prigione. Perché ogni posto deve avere una prigione. Se sei già all’ospedale e ti senti male, cosa fanno? Ti mettono in terapia intensiva, che è l’ospedale dell’ospedale. Se sei in prigione e vogliono punirti è uguale: deve esserci qualcosa. Deve esserci sempre qualcosa da togliere, altrimenti tutto si ferma». Chi parla è un ergastolano che ha sulla coscienza un sequestro di persona e un omicidio perpetrato in carcere. Nel mentre contempla, dentro un tempo buio e senza tempo, quel piccolissimo spicchio di mondo che gli è concesso dall’isolamento, il suo sguardo è così detenuto, il suo corpo così costretto, i suoi pensieri talmente compressi, da considerare i detenuti ordinari, quelli che vivono secondo una normale e collettiva liturgia carceraria, quasi prossimi alla libertà, seppure avvertita come sempre più astratta e irreale, sino a coincidere, oltre le mura del carcere, con niente più che una smisurata e remota fantasmagoria. Ecco perché a Torchio non interessano i fatti, pochi ed essenziali, che racconta, quanto invece il linguaggio e, chiamiamola così, l’epistemologia del narrare, fondata sul progressivo restringimento degli spazi, su una claustrofobica verticalizzazione di atti e rapporti. Ecco: in quale modo il carcere è raccontabile? Domanda che implica una risemantizzazione dell’esistenza entro quella dimensione parossistica e, dunque, antropologicamente speciale: là dove il captivus, e cioè il prigioniero, non è per ciò stesso il malvagio, ma un uomo che è stato carnefice e che vive la sua vita ai minimi termini, al nudo grado zero, da vittima, epperò così da riuscire a intensificarla in modi che sono sconosciuti a chi vive nell’inconsapevolezza del “fuori”. Se una crisi del romanzo e della pura narrazione oggi effettivamente c’è, Torchio ci dimostra che è possibile uscirne solo con una grande immaginazione gnoseologica, dentro una prosa – dentro un discorso né fiction, né saggio – che non si sa più che cosa sia.