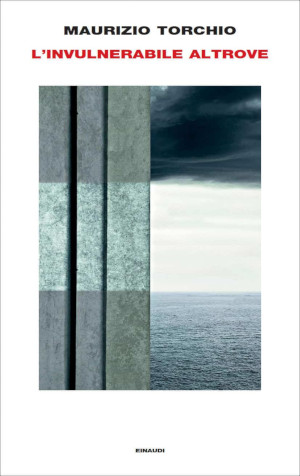Cattivi/Restare rinchiusi, i cattivi di Maurizio Torchio
Da mauriziotorchio.
< Cattivi
Restare rinchiusi, i cattivi di Maurizio Torchio
Dal punto di vista etimologico, la parola “cattivo” viene dal latino captivus, parola che assumeva il significato di prigioniero. Poi la lingua con il suo corso ne ha mutuato pian piano la definizione, facendole assumere il significato morale di “malvagio, perverso e disposto al male”. Si può parlare appunto di sfumature di significato, perché prigioniero diviene chi è cattivo e chi è cattivo è giusto che diventi un prigioniero. Ecco dove questo collegamento semantico trova la sua ragione di essere ed ecco da dove può quindi essere interessante partire per una riflessione su tali argomenti.
È questo quello che fa Torchio e sembra infatti questa una delle domande che la lettura si trascina: chi sono veramente i cattivi?
La storia di “Cattivi” di Maurizio Torchio è la storia di un ergastolano, un carcerato che, inizialmente condannato ad una reclusione di due anni e due mesi per il rapimento della “principessa del caffè”, durante un trasferimento uccide in cortile con trentacinque coltellate la guardia che lo sta trasferendo, trasformando la sua pena nell’ergastolo, nel “fine pena mai” rappresentato dall’inserimento nei computer della metafisica data di fine pena “99/99/9999”. Questa finta eternità sarà trascorsa dal condannato in isolamento, la prigione della prigione “perché ogni posto deve avere una prigione. Se sei già all’ospedale e ti senti male, cosa fanno? Ti mettono in terapia intensiva, che è l’ospedale dell’ospedale. Se sei in prigione e vogliono punirti è uguale: dev’esserci qualcosa. Dev’esserci sempre qualcosa da togliere, altrimenti tutto si ferma”. E una delle tante declinazioni che assume la vita in carcere è proprio quella della privazione, una privazione che però presenta una forma del tutto particolare. Quando non si ha nulla, qualsiasi cosa diviene un tesoro ed è per questo che “a volte ti danno delle cose perché ti venga paura di perderle”. È la constatazione che nulla è scontato, tutto può essere tolto (e il prigioniero di Torchio fa l’esempio dell’acqua prima delle perquisizioni, “non la comandi più della pioggia che cade fuori”) perché bisogna sempre ricordare che la vita scorre dietro una saracinesca e tra mura alte e invalicabili, non c’è libertà se non quella concessa da altri, “in un carcere che funziona, i detenuti non decidono niente”.
In esergo al testo Torchio pone una citazione tratta da “Sogno sul monte della scimmia” di Derek Walcott che recita: “Gli storpi, gli storpi. Sono gli storpi a credere nei miracoli. Sono gli schiavi a credere nella libertà”. Ma come possono i carcerati, e in particolar modo un ergastolano come il protagonista, pensare alla libertà? Fin dove si può spingere una riflessione in tal senso e a quali conclusioni può arrivare? La grandezza del libro di Torchio sta nella capacità di raccontare in maniera corale la storia di un singolo, un singolo che rappresenta tutti i prigionieri delle carceri. Il racconto di chi è in fondo, di chi vive in isolamento con la sola compagnia dei suoni che vengono dall’esterno, in un posto dove non c’è più neanche la luce (ma quando poi si vive nel buio e gli occhi sognano attraverso i colori che dietro le palpebre colano, “quando arrivano le cascate di colori, loro accendono la luce. E la lasciano accesa per sempre. Le cascate spariscono. Emerge il vuoto nella tua cella, con la lampadina blindata”); è un racconto che prende vita da una capacità di osservazione che si sublima, che porta a riconoscere i passi di chiunque cammini nel carcere, a riconoscere dall’atmosfera l’arrivo di una perquisizione o di una punizione delle guardie e che permette di riconoscere il passo dei cani nel cortile. Si crea un potenziamento dei sensi che porta a vivere in simbiosi con il carcere che sembra assumere una forma umana. Ed è grazie a tutto questo che si diventa conoscitori di tutto quello che succede e l’isolamento, nel fondo del carcere, dà la paradossale possibilità di vedere tutto quello che succede fuori da quella stanza. Così il narratore può raccontare tutto: le gerarchie e le pratiche sadiche che si svolgono tra quelle mura, le storie di Piscio e di Toro e la nuova corrente criminale rappresentata dagli Enne (“gli Enne hanno continuo bisogno di ammazzare e venire ammazzati”).
Questo diario di un prigioniero condannato all’ergastolo vive di un paradosso avvertibile alla semplice lettura: nonostante la sicurezza di una condanna al carcere fino alla morte, la prigione, con le sue dinamiche e il suo annientamento che non diviene mai totale ma che si spinge comunque fino alla sua soglia, porta sempre a pensare ad un dopo. Il pensiero, nonostante la morte del corpo fisico dei carcerati, poveri di allenamenti se non i fanatici Enne descritti dal narratore, continua a lavorare, a riscattare l’immobilità del corpo. Ed è la struttura stessa del carcere che ha bisogno di questo moto del pensiero; per continuare ad esistere il carcere deve dare la possibilità di poter pensare ad uscire ed è per questo che, seppure nella realtà non ci sono possibilità di lasciare il carcere, esso “ti costringe a continuare a pensare al dopo”. Questa fuga in avanti del cogito è ciò che porta poi il narratore a dimenticare la vita precedente, inesistente quasi del tutto all’interno del suo racconto se non per quei frangenti che riguardano il rapimento che lo ha portato in questa situazione. La mancanza di un’innocenza precedente al reato, è chiaro simbolo di un’assenza, o meglio di una rimozione: la vita è nel carcere, non esiste nulla se non collegato ad esso e al pensiero, un giorno, di lasciarlo. In questo diario intimo l’infanzia non è mai richiamata (se non per un brevissimo accenno), né l’atmosfera di quell’età della vita. Eppure, raccogliendo il carcere tutta la vita e rinchiudendola tra quattro mura, dall’isolamento lo studio dei reclusi mostra che esiste anche un ritorno all’infanzia, nell’assurda dimensione di privilegio che si vede per esempio nei regalini, che fanno letteralmente impazzire i prigionieri: “In carcere ho visto rivolte sventate distribuendo caramelle. Giuro, caramelle: da prigioniero hai gli sbalzi di umore dei bambini, perché qualsiasi cosa, anche la più piccola, ti occupa subito tutto il campo visivo”.
“Le persone sono fatte così. Tenere qualcuno chiuso in un posto, anche solo per un paio di mesi, colpisce la loro immaginazione. Soprattutto i poveri. Ci sono poveri che se sanno che un ricco è costretto a fare una brutta vita per un paio di mesi piangono, perché pensano che non è abituato. Piangono per le principesse. Piangono perché pensano sia importante che qualcuno viva bene dall’inizio alla fine”. Questo racconta il protagonista del romanzo di Torchio quando ricorda il rapimento ai danni del re del caffè, illustrando il suo ruolo di carceriere e il cedimento umano, di fronte ad una vita rinchiusa. Leggendo tra le righe di questa citazione, è come se l’ergastolano inserisse un messaggio dentro una bottiglia, chissà se arriverà, eppure il tentativo necessita di essere fatto: l’immaginazione di tutti viene colpita pensando a persone rinchiuse in un posto, “anche solo se per un paio di mesi”, e per chi lo è per sempre?
Questo è uno dei motivi che rende il libro di Torchio uno dei più belli mai scritti sulla condizione carceraria; con il suo stile scarno e asciutto, a tratti anche disturbante per il suo realismo, Torchio crea una narrazione che, partendo dall’osservazione di un prigioniero speciale verso gli altri prigionieri ordinari, tratteggia dall’interno un mondo intero, mostrando tutto il suo dolore e la sua incapacità di guarire.