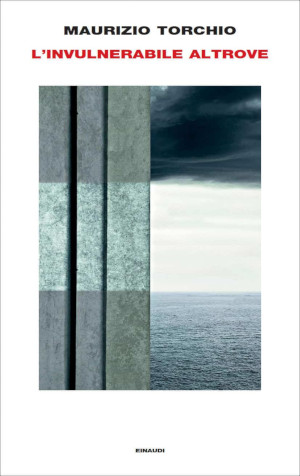Cattivi/Torchio in prigione, con esattezza materica e sensoriale
Da mauriziotorchio.
< Cattivi
Torchio in prigione, con esattezza materica e sensoriale
«Cattivi», il nuovo romanzo dello scrittore torinese classe 1970, da Einaudi. Notevole coesione stilistica: periodi brevissimi, icastici; parole, gesti e cose sbalzati e gravi. Maurizio Torchio mette in scena così l’io narrante di un recluso
«Ti senti meglio, diceva mia madre, se le parole ti calzano bene». Chi parla è un «cattivo», ovvero, per ben nota strada etimologica, «prigioniero» e «malvagio». È il protagonista del nuovo romanzo di Maurizio Torchio (Torino, 1970) ora uscito per Einaudi, Cattivi (pp. 186, euro 19,00). Un ergastolano che nell’infanzia è stato educato al valore delle parole: ne conosce la differenza col vuoto, e sa che in carcere non si può mentire, altrimenti «resti da solo, con quella voce che non è tua». Le sue parole sono lisce e compatte, ce le passa con la stessa consistenza, con la stessa corporeità che ha, nel mondo di fuori, una tazzina vera, bandita dal carcere perché potenzialmente pericolosa: «metti in bocca la tazzina ed è come avere un lavandino tra le labbra, tanto è spessa, pesante».
Cattivi è un romanzo di grande coesione stilistica: periodi brevissimi, spesso nominali, icastici; movenze anaforiche e paratassi; connettivi ridotti, scarsi, predilezione per la determinatezza dell’asindeto; parole gesti e oggetti sbalzati, con peso di materia, gravi; voce densa, ispessita. Chi scrive – ma il tono ha l’efficacia di un racconto orale –, chi racconta, è un io che quando compare, alla seconda pagina, dopo la descrizione minuziosa della perquisizione di un compagno rientrato da un permesso, lega il suo pronome a una negazione reiterata: «Io non sono mai uscito in permesso, né mai potrò uscirci». E poi, a ribadire con evidenza palmare l’assolutezza del suo universo di privazione, poche righe dopo ripete il suo pronome in un periodo nominale scarno, bisillabo, «Non io», e così chiude seccamente finanche la possibilità di incontrare donne ai colloqui. La scrittura è soppesata, tersa, d’inclinazione letteraria. Evocativa per ellissi e diversioni, per sospensioni o interruzioni a effetto. A tratti catalogatoria – «servono ginocchiere, un casco intorno alla testa; sulle mani: guanti; davanti agli occhi: una visiera. Gommapiuma, cordura, kevlar. Sopra al petto, davanti al cuore, ceramica antiproiettile. Paragambe, parabraccia. Manganello, scudo, spray» –, puntuale e scandita. Perché pararsi per andare a picchiare un detenuto è un rituale e le armature amplificano il senso di sé e della violenza. Gli oggetti, nella semplice, nuda elencazione, si caricano delle emozioni provate sia da chi li indossa, sia da chi li subisce. La scrittura di Torchio punta all’esattezza materica e sensoriale, e attraverso questa all’impatto sul lettore. L’io narrante punta a guardare la realtà con occhio vigile e a darsi spiegazioni, punta alla lettura gnomica dei gesti e delle scelte: «il nero assorbe la paura da chi lo indossa, e la proietta fuori»; «fra chi ha le chiavi e chi non le ha non può esserci vera amicizia»; «non ci sono miracoli senza grotte, senza terra e pietre intorno».
L’aspetto più riuscito del romanzo è il tono del protagonista condannato al «senza fine mai»: il suo modo di esporre osservazioni e ricordi come da effettivi venti anni di reclusione, la conoscenza accumulata, le regole di comportamento introiettate, la capacità ormai acquisita di immaginare nei più minuti dettagli anche fatti che non vede, per i quali usa un tempo futuro che dà certezza alla congettura, che la fa lucida di smalto. Ha assorbito il respiro della struttura che lo punisce: «a forza di stare fermo, qui sotto, mi sono radicato nel cemento, innervato per tutto il carcere».
A far sentire certa oralità, e il farsi del pensiero, sono la fluidità dei trapassi e delle connessioni analogiche. E la naturalezza del procedere narrativo, naturalezza artata, poiché la scrittura è polita, le interpunzioni fitte, ritmanti. Il romanzo è costruito intorno a un’individualità privilegiata, poche altre vi si accostano. Sprofondato, com’è, nei pensieri di chi narra, ha un forte sapore esistenziale, percorso a tratti da venature sentimentali. Se a dominare è l’espressione dell’io, l’uso mescolato delle particelle pronominali – si, ti, ci – è spia di un incedere più mosso, eterogeneo: dalla forma impersonale, al tu pure impersonale ma più coinvolgente, alla coralità del noi.
Cattivi dà corpo a una realtà concentrazionaria atemporale, in luogo non definito – prigione in cui convergono molteplici modelli dell’ampia letteratura carceraria d’ogni lingua –, un’isola come molte, tra quelle spopolate e incolte, adibite a sedi penitenziarie; del protagonista non conosciamo il nome, gli altri sono identificati solo da soprannomi – Toro, Piscio, Comandante, la Professoressa, Martini, gli Enne –, le guardie, salvo il direttore, non meritano neanche un soprannome. È un universo chiuso, in teoria finalizzato al recupero dei condannati, in realtà alla pura separazione dei pericolosi dagli innocui. Strumento considerato necessario al vivere sociale, al mantenimento della legalità, il carcere è in vero allegoria della società. È perfetto microcosmo per osservazioni sperimentali sulla vita di relazione, e sul suo abbrutimento, sul suo degrado. Ed è forza dello Stato – si rifletta sull’epigrafe dalla Politica di Aristotele scelta da Torchio, non nuovo a epigrafi da filosofi che ben conosce (Platone e Lucrezio nei suoi precedenti libri). Come ha ricordato Foucault, la prigione si richiama da anni al concetto del Panopticon, le cui procedure – «sorveglianza e osservazione, sicurezza e sapere, individualizzazione e totalizzazione, isolamento e trasparenza» – sono «forme concrete di esercizio del potere». Forme che investono i detenuti come torture inappellabili: dure sono le rievocazioni che il protagonista fa dei suoi anni d’isolamento, del buio totale inflitto per giorni, «Buio. Tutto l’infinito buio prima di nascere. Tutto l’infinito dopo». O della luce mai spenta di una lampadina blindata che fa emergere il vuoto della cella con il pavimento inclinato verso il buco centrale, «la tua bara converge verso quel buco».
Il cemento è un oltraggio, il rumore delle chiavi d’ottone contro le sbarre per controllarne l’integrità è un oltraggio, l’odore della spazzatura che marcisce intorno al carcere e «sale fino al cielo» è un oltraggio. Così l’abbaiare continuo dei cani nell’intercinta, così l’incredibile (ma autentico) pane punitivo. E «ogni oltraggio è morte», scriveva Gadda nella Cognizione del dolore.
La distinzione dei blocchi, sorvegliati/sorveglianti, è chiara in superficie, ambigua, invece, e complessa a scendere appena sotto. Che il carcere a suo modo dia certezza – anche tremenda – è cosa ovvia, che esista una distanza tra chi è dentro e chi è fuori, oltre i muri, è vero ma solo in parte. Soprattutto è sfuggente lo statuto di vittima: ci possono essere vittime che hanno ucciso, vittime che si legano ai loro carcerieri, e carcerieri a loro volta vittime. Il protagonista lo sa bene, per essere stato, nel mondo, carceriere di una donna sequestrata. Sette mesi in un nascondiglio scosceso nel fianco d’una montagna. E ci possono essere anche padri che si legano all’assassino del proprio figlio, perché «è difficile capire cosa fa il dolore, come lavora, come scava, chi mette in contatto e chi separa». Forse finiamo per amare, paradossalmente, chi ci toglie qualcosa.
Solo un timore può destabilizzare ancora questa voce narrante che ha sopportato di uccidere una guardia e di pagarne le conseguenze, e che si sospetta – suo unico rimorso – assassino manovrato, strumento nelle mani di altre guardie. Solo la scomparsa dei carcerieri lo inquieta. Restare recluso dimenticato in un carcere deserto, silente, privo di mezzi. Allegoria e riflessione si aprono, allora, e investono pienamente la libertà, e il potervi credere.