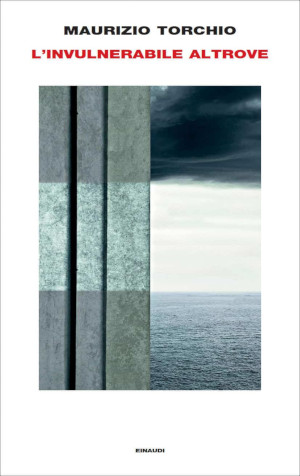L'invulnerabile altrove/L’invulnerabile altrove
Da mauriziotorchio.
< L'invulnerabile altrove
L’invulnerabile altrove
Ci sono due donne, in questo romanzo: entrambe hanno un corpo, dei capelli, stanno in un tempo e in uno spazio ben definiti, materici e sfuggenti insieme. Una sola ha un nome: è Anna, ha vissuto a Londra nel secolo scorso, fabbricava fiammiferi in un’epoca dalle tinte dickensiane, impastata di nebbia e densa di fumo pesante. Anna ha avuto molti figli – così tanti da non ricordare nemmeno come si chiamassero – adesso è morta, sta nel Dopo. L’altra donna è un’ingegnera, ha un marito e un amante, vive nel Prima, non è morta: sanguina ancora, va in ufficio, fa la spesa, si impegna quando sceglie la verdura dagli scaffali. Chi dice “io”, in questo romanzo, è la donna del Prima, senza nome: Anna è la voce che abita la sua mente, la donna nascosta nella sua testa, “come un pacchetto di caramelle sotto il cappotto.” Le parla quotidianamente: sulla pagina, le sue parole sono evidenziate con un segno grafico, un’evidenziazione grigia.
È difficile raccontare la trama del nuovo romanzo di Maurizio Torchio, L’invulnerabile altrove (Einaudi, Supercoralli, 2021, 160 pp.) forse perché questo libro si dipana saggiamente su piani alternativi, non convenzionali, srotolando lentamente fischi e segni di riconoscimento che uniscano l’aldilà all’aldiquà. Il suo miracolo sta nella costruzione narrativa, nell’intreccio di voci, corpi e parole che si riversa compatto sulla pagina, e nel gioco del comunicare, nel dire “qui” e nel dire “ora”.
Uno degli strumenti principali di questo gioco è l’abile uso della deissi, che come noto indica la cerniera fra testo e contesto, mediante l’impiego di elementi particolari, quali pronomi personali e aggettivi dimostrativi, avverbi di luogo e di tempo, utili per collocare una frase nello spazio e in una cronologia. Quando due interlocutori sono nello stesso luogo, nello stesso istante, si dice che “condividono il centro deittico”. Anna e l’io narrante non conoscono lo stesso centro deittico e di gravità: abitano due mondi diversi separati da un diaframma sottile ricamato di parole, non possono fare esperienza l’una della realtà dell’altra se non attraverso quello che si raccontano.
Entrambe si considerano matte. Vivono il contatto come colpa, portano lo stigma della diversità, coltivano con impazienza la speranza di poter guarire. Anna, in particolare, ha urgenza di farlo. La cura per ‘tornare in sé’ è concepire un figlio, far fiorire una vita in una storia di morte, dare alla luce (quale luce?) un bambino che sia alleanza tra due mondi: per questo l’ingegnera è pronta a prestare il suo corpo ad Anna affinché lei abbia un rapporto sessuale con il suo amante. Il bisogno di un figlio come rimedio e della gravidanza come esperienza che salvi è forse indice di qualcosa di sinceramente profondo: Massimo Recalcati ha scritto che la madre ‘tende le mani alla vita che venendo al mondo invoca il senso’ (Le mani della madre, Feltrinelli, 2015, 187 p.) – e forse è questo il cuore di questo desiderio che unisce le due donne: invocare il senso del garbuglio in cui si trovano attraverso un figlio che modifichi il volto del mondo. Ancora, ‘insieme alla vita del figlio viene alla vita anche il mondo’: la nascita del figlio sancisce uno spartiacque ‘tra il mondo di prima e il mondo di adesso’, e può dare avvio a nuove rotazioni e rivoluzioni. È questa la guarigione che le due donne cercano, quella che vorrebbero condividere?
Un giorno la donna del Prima dà appuntamento al suo amante, posiziona una videocamera su uno scaffale, inizia a registrare, attende l’uomo, quieta. Si addormenta, temendo di cadere. Poi riapre gli occhi e non c’è più: “è già sicuramente Anna”, coperta dal velo del suo corpo: l’ingegnera guarderà se stessa, dopo, nello schermo del marchingegno elettronico che le permette di capire cosa sia successo mentre cedeva all’altra donna – l’altra voce – le sue gambe e le sue braccia, le sue labbra e i suoi seni. Guarderà la videocamera, i minuti che si rincorrono sullo schermo elettronico, pensando che il tempo sia tutto quello che possiede. Sulla pagina il tempo del racconto si fa lunghissimo, dilatato, ma le parole leggere calcano un tempo della storia più esile, fragile, forse quello di un bacio, tempo di finzione. “Noi rassicuriamo lui in bilico tra due mondi.”
È in queste pagine che si annida il nucleo centrale del romanzo di Torchio, la sua arte di muoversi piano su un crinale (siamo tutti già morti senza saperlo?) fra il qui e questo invulnerabile altrove. Le due donne si parlano, la donna del Prima racconta alla donna del Dopo cosa vede nel video registrato, “l’anima si stacca dal corpo e lo guarda dall’alto”. Ma qual è il senso di questo scrutarsi? Cosa guardo quando guardo me stesso? Cosa guarda l’ingegnera quando guarda il suo corpo abitato dall’alterità con cui condivide il teatro della mente? Nei suoi Cahiers, Paul Valéry ha scritto: «Guardarsi allo specchio non significa forse pensare alla morte? Non vi scorgiamo forse la nostra parte più peritura? L’immortale vi vede il suo mortale. Uno specchio ci fa uscire dalla nostra pelle, dal nostro viso». Valéry individuava nello specchio lo strumento adatto per esaminarsi ed accertare (o accettare) la propria identità; la certezza dell’identità della protagonista vivente del libro di Torchio è incrinata dalla stortura della sua mente, la videocamera restituisce le crepe dell’io. Fra i pixel – in un non-spazio nuovo rispetto a quelli finora allestiti – sono nascoste una donna viva e una donna morta: dove finisce la prima? Dove inizia la seconda? La pagina si riempie del gioco dei deittici, i punti di vista si impigliano fra loro, ci si scambiano pronomi, dolori e lividi. “Tu sei andata a sbattere ma il livido è qui, sopra la mia coscia, a te cosa è rimasto?”
Dove sta chi legge rispetto a queste due donne? In quale vertiginoso cono prospettico è incluso? Torchio è artefice di una sapiente danza letteraria: sposta il lettore in un centro spaziale e temporale che non esiste, costringendolo ad abitare le imposture altrui, a brancolare nel buio di una mente altra. Chi legge non è collocato in un piano di realtà, ma sta nascosto nell’interstizio dove germogliano i pensieri e i dialoghi di un altro sé col suo demone; farsi posto nella mente dell’alterità è un’acrobazia disorientante, ed è un grandioso compito di cui solo la letteratura può essere capace. Costruire ponti impossibili, schierare parole sulla soglia, in limine. C’è una litografia di Escher, Vincolo di unione, che ritrae due volti srotolati che si incastrano, nastri che generano una doppia unità. Forse è così che Torchio ha immaginato queste due donne, collocate in una dimensione eraclitea confluiscono l’una nell’altra – non contrarie ma complementari, come immagina la donna del Prima, “simmetriche” persino nella zoppia, nei difetti che si compensano.
Il mondo del Dopo plasmato da Torchio non ha nulla di dantesco: è piuttosto un Giardino delle delizie affollato di corpi che diventano torri umane, lunghe catene di uomini, donne e bambini. Come nei quadri fiamminghi, Torchio dipinge la molteplicità per contrastare l’horror vacui. Ma l’altrove assume anche i contorni rarefatti delle poesie di Emily Dickinson, “C'è un altro cielo, / sempre sereno e bello, / e c'è un'altra luce del sole, / sebbene sia buio là” – e riporta le ferite di luce che riempiono Averno di Louise Glück: “La luce è cambiata; / ora il do centrale ha un suono più cupo. / E le canzoni del mattino suonano troppo studiate. // Questa è la luce dell’autunno, non la luce della primavera. / La luce dell’autunno: non sarai risparmiata […]”. Entrambe tradotte in italiano da Massimo Bacigalupo, poetesse dell’altrove, dell’andare oltre “doloroso, nostalgico, duro” (ne ha scritto per Doppiozero Gianni Montieri).
Quello del Dopo è un mondo “di luce”, “come al circolo polare d’estate. Non c’è un sole, in un punto, e l’azzurro intorno, ma un bianco opaco, che cade da tutte le direzioni, e ci assorda”, le dune gialle di sabbia, il vento che gioca a disfarle. Ci sono due stagioni, nel Dopo: la notte e il giorno. Quando la notte arriva, ai morti vengono tagliati i capelli. Nel Dopo Anna ha incontrato e perso Luigi, un uomo che parlava col Prima – per questo “un idiota” nel senso etimologico di «individuo privato, senza cariche pubbliche», «che sta a sé». Luigi ‘stava a sé’, parlava con qualcuno di interessante, non è riuscito a smettere. È per questo che è rimasto indietro rispetto alla carovana di corpi con cui cammina Anna? È il legame col Prima che ha allontanato Luigi da lei e dagli altri? Anna ha paura di condividere con lui questa sorte. Anna, “vocale aperta e anteriore”, donna di ieri, donna dell’altrove, è fra le due protagoniste la più profonda: teme, trema, prova vergogna, ricorda. È volutamente “rivestita di particolari”, mentre l’io narrante è una donna nuda rispetto al passato. “Con mia madre facevamo le scatole dei fiammiferi, a casa, scatole sparse ovunque per far asciugare la colla, scatole e spazio per poco altro”. Fiammiferi e fiori di carta, fratelli e sorelle da accudire e da cullare: Anna racconta la sua fame, il tugurio senza finestre che ha abitato, il desiderio di possesso degli oggetti nella vita di prima.
Maurizio Torchio dice dell’altrove che è invulnerabile, ma a me non pare, dal momento che è ferito e feribile, conosce il dolore che nasce dalla perdita, la fatica del camminare, del tessere legami, del riconoscere le imposture della mente, del dirsi malati e del voler guarire. Torchio organizza una macchina narrativa complessa, poi accoglie il lettore nel nulla, nella waste land della finzione, insegna il dolore della zoppia. Aggira lo spettro della morte, i limiti della vita pensante e della ragione (Cosa c’è dopo?, Come sta chi sta dopo?), e lo fa costruendo un mondo, come sanno fare i bravi romanzieri. Scrive un libro che va oltre, altrove, e per questo sa restare.